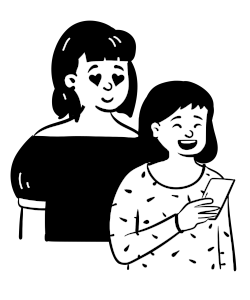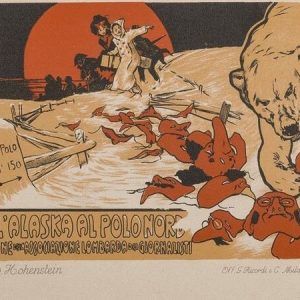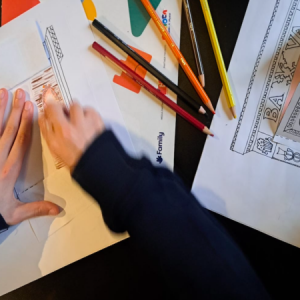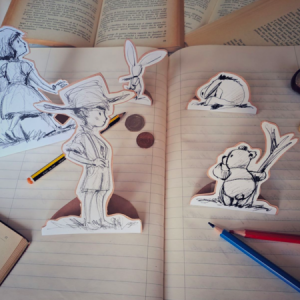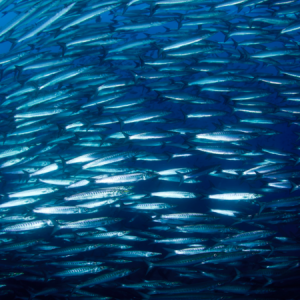Il progetto MatGuilt punta i riflettori sul senso di colpa genitoriale e in particolare della pressione sociale subita dalle madri, un fenomeno diffuso anche oltre i confini italiani
A chi di noi non è capitato di chiudere la porta di casa per andare al lavoro – o semplicemente per prendersi un po’ di tempo per sé – mentre tuo figlio o figlia ti corre incontro piangendo, chiedendoti di restare? Ecco, quel nodo allo stomaco ha un nome: senso di colpa, che in questi casi si impossessa soprattutto delle madri. Ed è lo stesso quando ti dimentichi la merenda, gli o le rimetti la maglietta macchiata e ti perdi il messaggio della festa di compleanno nella chat di classe.
Quello che non sappiamo è che questo senso di colpa ha delle conseguenze: influenza la conciliazione tra lavoro e famiglia, le scelte riproduttive e l’occupazione, in un Paese come l’Italia dove le donne lavorano poco e hanno pochi figli, ma sono ancora le principali responsabili della cura.
Il progetto MatGuilt (Maternal guilt: Measurement, correlates, and policy solutions in the Italian context), avviato nel 2023 e guidato dalla professoressa Giulia Dotti Sani dell’Università Statale di Milano, esplora le implicazioni sociali di questo sentimento, con particolare attenzione a quello materno. Il progetto, articolato in una survey nazionale su 6.000 persone, ha portato avanti 50 interviste approfondite a madri lavoratrici e anche un workshop internazionale con esperte da Olanda e Regno Unito. Presto il volume, “The Price of Motherhood”, sarà pubblicato da Palgrave-McMillan e i dati saranno resi disponibili in open access.
Un fenomeno diffuso e trasversale
Dallo studio emerge che il senso di colpa genitoriale è ampiamente diffuso, coinvolgendo sia madri che padri, seppur con differenze di genere marcate. Le madri, in particolare, vivono una pressione sociale legata a quell’ideale materno che le porta a sentirsi inadeguate quando non riescono a dedicarsi intensamente ai figli. I padri, invece, sperimentano sensi di colpa legati al tempo e al sostegno economico. Il progetto ha evidenziato anche un senso di colpa “anticipato” tra i giovani adulti senza figli, segnale di un clima culturale che genera ansia verso la genitorialità.
Le difficoltà economiche, la mancanza di welfare e la tensione tra lavoro e famiglia contribuiscono a questo disagio, che si riflette anche nei bassi tassi di natalità. Le esperienze internazionali confermano che, pur con differenze locali, esistono emozioni comuni legate alla genitorialità e alla pressione sociale.
Le proposte: ascoltare le emozioni e ripensare le politiche
Durante il workshop conclusivo, è emersa la necessità di un cambio di paradigma: le emozioni genitoriali, spesso ignorate, devono essere ascoltate e studiate. La co-creazione delle politiche, come suggerito dagli studi inglesi, può essere una via efficace per coinvolgere direttamente i genitori nella definizione di soluzioni.
La proposta? Avviare campagne informative mirate e di ampliare il campo di ricerca includendo emozioni positive, famiglie monogenitoriali, genitori dello stesso sesso e l’influenza dei social media. In Italia, il modello familiare è ancora in bilico tra tradizione e innovazione, ma il coinvolgimento crescente dei padri e l’evoluzione dei ruoli genitoriali indicano che il cambiamento è già in atto, anche se ancora privo di un’alternativa chiara e condivisa.