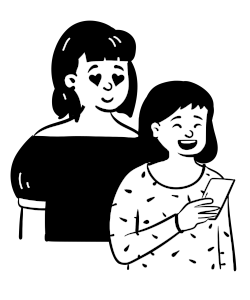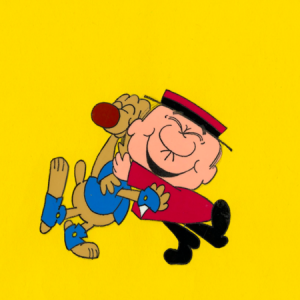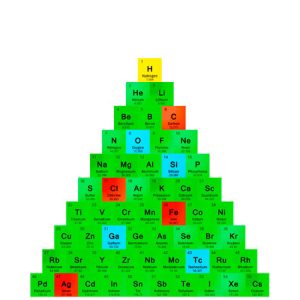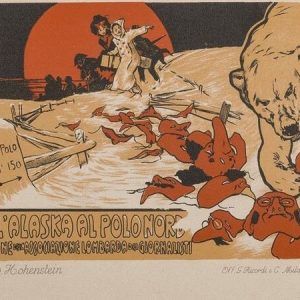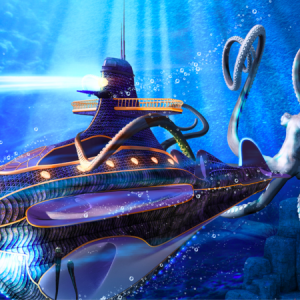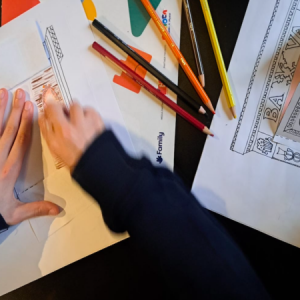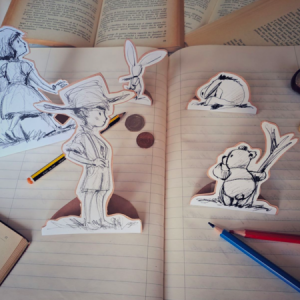Il rapporto Save the Children “Le equilibriste” esce per il decimo anno consecutivo e ci riporta che lo svantaggio occupazionale delle donne in Italia, e in particolare delle madri, persiste come una sfida complessa e multidimensionale
Il occasione della Festa della mamma, “Le equilibriste: la Maternità in Italia nel 2025″, arriva puntuale, con la sua decima edizione, insieme alle storie di mamme equilibriste, e lo studio l’Indice delle Madri, in collaborazione con l’ISTAT, che include una classifica delle Regioni italiane dove per le mamme è più facile o difficile vivere. Primo dato di partenza è rappresentato dai 370mila nati nel 2024 (-2.6% rispetto al 2023) e il numero di figli per donna, che a 1,18 rappresenta il minimo storico. Oltre a un’inevitabile cambiamento culturale e sociale, segue un quadro dettagliato della situazione di disparità e svantaggio che può aiutarci a comprendere parte delle ragioni del calo demografico.
Le mamme single emergono
Complice un aumento delle separazioni e non solo, il numero di famiglie monogenitoriali in Italia è aumentato del 44% negli ultimi dieci anni. Nel 2021, si contavano oltre 3,8 milioni di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli, e il 77,6% di queste famiglie era costituito da madri sole. Sono quindi raddoppiati, e si stima che entro il 2043 il numero di madri single raggiungerà i 2,3 milioni: segue un quadro che ne descrive una vita a ostacoli. Sono infatti definite le equilibriste tra le equilibriste. Un dato che porta la politica a dover affrontare il tema vista la crescente difficoltà che i genitori single, e in particolare le madri sole, affrontano, soprattutto in termini di occupazione e rischio di povertà. Tale rischio, infatti, può riguardare 8 donne su 10.
Oltre ai dati, un approccio di ricerca qualitativa segue il rapporto di analisi dei dati: Storie delle mamme equilibriste racconta le esperienze di madri che affrontano quotidianamente le sfide della maternità in Italia. Sono storie di donne che, tra lavoro, famiglia e ostacoli burocratici, cercano di trovare un equilibrio in un sistema che spesso non offre loro il supporto necessario. Un invito a riflettere su quali siano davvero le esigenze e i bisogni, e quali le politiche di sostegno alla maternità e le misure necessarie per garantire alle madri italiane di poter aspirare, e raggiungere, condizioni di vita migliori.
Come ogni anno, il rapporto include l’Indice delle Madri, elaborato in collaborazione con l’ISTAT che classifica le regioni italiane in base alla qualità della vita e ci indica dove è più facile essere mamma. Anche nel 2025, la Provincia Autonoma di Bolzano si conferma la regione più “mother-friendly“, seguita da Emilia-Romagna e Toscana. Al contrario, le regioni in cui le mamme incontrano maggiori difficoltà sono Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, che occupano gli ultimi posti della classifica. L’ennesima frattura tra Nord e Mezzogiorno.
Un disequilibrio del carico lavorativo
Nel 2024 le donne hanno lavorato più dei papà, e il divario nel carico di lavoro complessivo tra madri e padri continua a essere significativo. Secondo il rapporto “Le Equilibriste 2025”, le madri dedicano in media 3,5 ore al giorno alle attività di cura e gestione domestica, contro le 1,5 ore dei padri.
A questa disparità si aggiunge anche il divario salariale tra madri e padri. Le donne con figli guadagnano in media 18% in meno rispetto ai padri, una differenza che si accentua nelle regioni con minori servizi di supporto alla genitorialità. Il divario salariale tra madri e padri rimane quindi significativo e la disparità che si accentua nelle regioni con minori servizi di supporto alla genitorialità. Inoltre, dopo la nascita di un figlio, la carriera delle madri subisce un rallentamento: il 20% delle donne lascia il proprio impiego, mentre il tasso di occupazione paterna resta stabile. L’assenza di politiche di conciliazione efficaci e la scarsa redistribuzione del carico di cura contribuiscono a mantenere questo gap, rendendo ancora più complesso per le madri rimanere nel mercato del lavoro.
Questa disuguaglianza si traduce in child penalty, ovvero la penalizzazione economica e lavorativa che le donne subiscono dopo la maternità.
Ripensare le politiche per le famiglie
Il quadro emergente è quindi quello di una maternità sempre accompagnata da numerose difficoltà. Il tasso di natalità resta è tra i più bassi d’Europa, ma lo è anche l’occupazione femminile. Politiche di sostegno alle famiglie frammentarie e poco strutturate, andrebbero sostituite da interventi stabili e integrati, sia dal punto di vista economico che nei servizi educativi e di cura per l’infanzia.
il tasso di copertura degli asili nido resta insufficiente, con costi elevati che ne limitano l’accessibilità per molte famiglie.
Ma anche la situazione delle Scuole per l’Infanzia (3-6 anni) andrebbe migliorata: sono tante, infatti, le scuole in particolare nelle regioni del Sud che non garantiscono il tempo pieno. E un pò ovunque, nord compreso, fino alla metà dei posti disponibili sono garantiti dalle scuole paritarie confessionali, che hanno costi più alti delle strutture comunali e statali, i quali, nonostante il calo demografico, non riescono mai a soddisfare tutte le richieste.
Una riduzione dei costi dell’assistenza all’infanzia favorirebbe l’occupazione femminile: secondo uno studio, abbassare le rette degli asili nido potrebbe diminuire la child penalty dal 33% al 27,6%.
Secondo l’Alleanza per l’Infanzia, tre sono le priorità per migliorare la condizione delle madri: un sostegno economico adeguato, politiche di conciliazione famiglia-lavoro per un equilibrio di genere e il diritto all’educazione e alla pari opportunità per i bambini.
Affinché le madri possano realmente scegliere di partecipare al mercato del lavoro, è necessario un cambiamento culturale che valorizzi anche il coinvolgimento dei padri. Un intervento chiave sarebbe il congedo parentale equamente distribuito, che incentiva i padri a partecipare maggiormente alla cura dei figli, riducendo il carico di lavoro domestico sulle madri. E’ ormai essenziale promuovere una cultura della genitorialità condivisa, in cui il ruolo paterno sia valorizzato e le madri non siano costrette a scegliere tra carriera e famiglia. Solo con interventi strutturali e un cambiamento sociale si potrà garantire una maggiore equità nel mondo del lavoro.